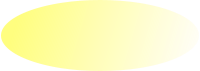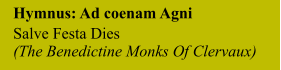sanseveropuntoit, 21 febbraio 2025

IL CD-ROM


“SAN SEVERO 2000”
Con
la
soppressione
degli
ordini
mendicanti
del
1811
venne
chiuso
anche
il
convento
di
San
Bernardino
degli
Osservanti
che
distava
dall’abitato
«circa
duecento
passi»
e
poteva
ospitare
quindici
frati,
ma
ve
ne
erano
undici, sei sacerdoti e cinque laici, che vivevano di elemosina.
Il
monastero
era
particolarmente
utile
alla
popolazione
perché
in
esso
vi
era
«l’infermeria
della
Provincia»
che
occupava
undici
stanze
e
nella
quale
affluiva gente da ogni dove.
Quando
si
incominciò
a
diffondere
la
notizia
della
soppressione
del
convento,
infatti,
il
vicario
capitolare
canonico
Bonaventura
scrisse
all'intendente per rimuoverne il proposito.
Approfondimento
Nella
lettera
del
vicario
capitolare
si
affermava
che
il
convento
degli
Osservanti
era
necessario
alla
popolazione,
non
solo
per
i
sacramenti
che
amministrava
e
l'istruzione
che
dava
al
popolo,
ma
anche
e
principalmente
perché
in
esso
vi
era
un
laico
professo,
fra'
Matteo,
al
secolo
Francesco
Maria
Fratino
di
anni
59
di
San
Marco
in
Lamis,
«
Infermiere
e
chirurgo
»,
che
prestava
gratuitamente
la
sua
opera
«
e
cura
li
poveri
non
solo
di
questo
comune,
ma
benanche
quelli
di
tutte
le
vicine
popolazioni,
cioè
Torremaggiore,
S.
Paolo,
Lesina,
Apricena,
Castelnuovo,
Serra,
S.
Marco
in
Lamis,
S.
Nicandro
ed
altri,
li
quali
senza veruno emolumento vengono curati con ogni carità
».
Nel
convento
vi
era,
inoltre,
l’ospedale
per
tutti
i
religiosi
della
provincia
«
e
per
li
locati
che
discendono
dagli
Abruzzi
in
questa
Puglia
e
vengono
assistiti
e
medicati
con
tutta la Carità cristiana
».
E
per
questi
motivi
il
Vicario
capitolare,
non
solo
chiedeva
che
gli
Osservanti
continuassero
ad
operare
nel
convento
di
San
Bernardino,
ma
proponeva
di
«accrescere»
la
famiglia
di
altri
quattro
religiosi,
tenendo
conto
che
«sarebbe
la
medesima
onestamente
sostentata
dalle
volontarie
limosine
di
questa
popolazione»
la
quale
desiderava
«ardentemente»
che il convento fosse conservato.
Ma
l’intendente
non
condivise
le
motivazioni
addotte
dal
vicario
capitolare
e,
il
29
giugno
1811,
Matteo
d’Alfonso
incaricato
della
soppressione,
unicamente
al
sindaco
Giuseppe
Galiberti,
si
recò
nel
convento
e,
assistito
dal
padre
Vincenzo
Lombardí
di
Lucera,
facente
funzione
di
guardiano,
e
da
Pasquale
Toma,
sindaco
apostolico
ed
amministrativo
della
rendita
del
convento,
diede
inizio
alle
operazioni
di
soppressione,
inventariando
tutto
ciò
che
si
trovava
nella
chiesa,
nel
coro,
nella
sacrestia,
nella
cucina,
nel
refettorio,
nella
cantina,
nella
stalla
(dove
c'era
un
cavallo),
nel
chiostro,
nella casa della lavanderia e nella dispensa.
Il
giorno
successivo
Matteo
d’Alfonso
ritornò
dai
frati
e
con
lui
non
c’era
più
il
sindaco,
impedito,
ma
il
primo
eletto
Michele
Bucci,
facente
funzione
di
sindaco.
I
due,
accompagnati
dall’infermiere,
annotarono
accuratamente
gli
oggetti
rinvenuti
nella
«
infermeria
della
Provincia
»
e
nella
«
speziaria
»
tra
cui
bilance,
scatole,
vasi
di
ceramica
e
di
vetro.
Vennero
anche
inventariati
tutti
i
libri
della
biblioteca
dei
religiosi,
cinquanta
volumi,
«
diversi
e
vari
(...),
tutti
vecchi
ed
antichi
».
Quasi
tutti,
infatti,
erano
stati
stampati
a
Venezia,
Bologna,
Roma
e
Napoli
nel
XVII
secolo.
In
mezzo
ai
libri
vi
erano
anche
quarantasette
«borderò»,
cioè
distinte
di
titoli
di
credito,
intestate ad altrettanti cittadini di S. Severo.
Approfondimento
La
casa
religiosa
comprendeva
trentanove
stanze,
incluse
l’infermeria
e
la
cappella,
ma
erano
abitabili
e
fornite
di
vetrata
solamente
quelle
occupate
dai
monaci
e
quelle
adibite
ad
infermeria.
Davanti
al
convento,
la
cui
facciata
aveva
tre
balconi
con
ringhiera
di
ferro,
c'era
«
una
largura
»
con
tre
grossi
alberi
di
olmo
«
ed
una
croce
di
ferro
sopra
una
muraglia
»;
alle
spalle
c'era
un
orto,
di
circa
una
versura,
con
due
pozzi,
numerosi
alberi
di
olivi
e
di
«
diversa frutta
».
«
L’infermeria
»
del
convento
tirava
avanti
con
«
una
rendita
in
grano
»
di
tomoli
centodue,
ricavati
dall’affitto
di
venti
versure
di
terreno
al
Signor
Felice
La
Pietra,
e
di
tomoli
nove
dall’affitto
di
due
versure
di
terreno
«
chiamato
Boschetto
»
e
ducati
tredici
di
canone
d’affitto
pagati
da
Nicola
Morelli
per
mezza
versura
di
orto.
Queste
entrate
erano,
però,
insufficienti,
tanto
che
nel
1811,
per
«
la
sussistenza
»
dei
frati
e
specialmente
per
provvedere
alle
necessità
degli
infermi
della
provincia,
venne
contratto
un
debito di ducati 241,43.
Un
estremo
tentativo
di
salvare
il
convento
venne
fatto
dal
Provinciale
degli
Osservanti
della
Monastica
Provincia
di
S.
Angelo
di
Puglia,
padre
Giuseppe
da
Torremaggiore
che
il
1°
ottobre
1811
chiese
all’intendente
che
invece
del
convento
di
Manfredonia
venisse
conservato
quello
di
San
Severo
«
perché
come
convento
situato
circa
mezzo
miglio
lontano
dall’abitato,
il
Governo
non
ne
potrà
fare
verun'uso
ed
i
Religiosi,
come
luogo
di
infermeria,
e
posto
in
una
comune
più
grande
e
più
comoda
starebbero
migliore
e
non
verrebbero
a
perire
di
fame,
come
lo
sarebbe
in
Manfredonia
».
Il
25
ottobre
1811
il
sindaco
Giuseppe
Galiberti
e
Matteo
d’Alfonso
distribuirono
ai
frati
del
convento
«
per
bussola
»,
ossia
per
sorteggio,
tutti
i
«
generi,
mobili
ed
utensili
addetti
all’uso
della
Comunità»
e
invitarono
i
frati
a
lasciare
il
chiostro
entro
quattro
giorni
e
«portarsi
al
loro
destino,
ma
con le robe toccatili in sorte
».
Approfondimento
In
quella
circostanza
il
sindaco
non
seppe
resistere
alla
tentazione
di
conservare
per
sé
un
ricordo
del
convento
e
si
appropriò
di
un
orologio
appartenente
alla
comunità
e
del
letto
di
un
frate.
Su
segnalazione
del
padre
guardiano
Costantino
Iacobacci
di
Serracapriola,
l’intendente
lo
invitò
perentoriamente a restituire il maltolto.
LA SOPPRESSIONE DEL CONVENTO
DI SAN BERNARDINO DEGLI OSSERVANTI
CREDITI: “La soppressione degli ordini monastici in Capitanata” di Anna e Giuseppe Clemente